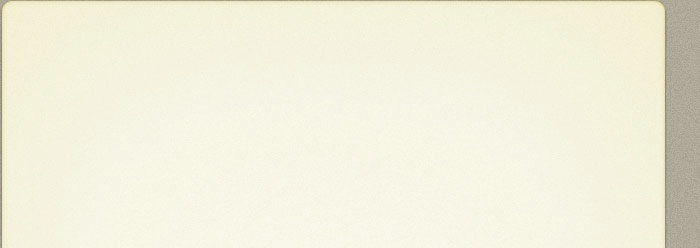
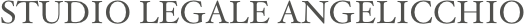
SI PUÒ DARE AL FIGLIO IL COGNOME MATERNO?
-
La questione, da tempo dibattuta in Italia, è stata rimessa al vaglio delle sezioni unite della cassazione. Cassazione civile 22 settembre 2008, n. 23934 ha pronunciato l’ordinanza di rinvio, chiedendo se sia oggi possibile assegnare al figlio il cognome della madre, alla luce della giurisprudenza costituzionale e dell’imminente mutamento delle norme comunitarie. Il quesito suggerisce che occorrerebbe verificare se la norma di sistema, che impone al figlio il cognome paterno, possa essere oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata ovvero, qualora tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai limiti dell’attività interpretativa, se la questione possa essere rimessa alla corte costituzionale.
-
A parte la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 27 settembre 1978 n. 376 (che invita gli Stati membri a eliminare ogni discriminazione fondata sul sesso nella scelta del nome della famiglia e nella trasmissione dei nomi dai genitori ai figli) e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 28 aprile 1995 n. 1271 (che chiede agli Stati membri di adottare misure appropriate per garantire una rigorosa eguaglianza tra i coniugi nella scelta del nome della famiglia) e 18 marzo 1998, n. 1362 (che, nel reiterare gli inviti precedentemente formulati, chiede agli Stati membri di indicare entro quale termine adotteranno le misure antidiscriminatorie), la norma di cui si discute appare contrastante con l'art. 16, 1 comma lettera g) della convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con L. 14 marzo 1958, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.
Della violazione degli articoli 8 e 14 della convenzione europea sui diritti dell’uomo la Corte di Strasburgo ha discusso in alcuni casi aventi ad oggetto vicende relative al nome patronimico. In particolare nei casi Unal Teseli c. Turchia (sentenza 16 febbraio 2005, che ha dichiarato priva di qualsiasi giustificazione oggettiva e ragionevole, in quanto non necessaria per soddisfare esigenze di salvaguardia dell'unità familiare, la norma che imponeva alla donna la perdita del cognome d’origine, in caso di matrimonio, o che, a seguito di recenti modifiche della legislazione turca, consente solo l'aggiunta di tale cognome a quello del marito), Stjerna c. Finlandia (sentenza 24 ottobre 1994, che, pur ammettendo che decisioni degli Stati membri in ordine al nome possono violare le disposizioni citate, ha in concreto negato la sussistenza di tale violazione nel rifiuto di consentire il cambiamento del nome usato da oltre duecento anni dalla famiglia del richiedente), Bourghatz c. Svizzera (sentenza 24 gennaio 1994, che ha dichiarato costituire violazione degli articoli 8 e 14 il rifiuto dell'autorità svizzera, di consentire al marito di aggiungere al nome della moglie, scelto dai coniugi come nome della famiglia, anche il proprio cognome d'origine).
In una fattispecie particolare (si trattava di figli di padre spagnolo e madre belga, con doppia cittadinanza spagnola e belga, ai quali il Belgio, stato di residenza, aveva attribuito il cognome paterno che il padre voleva correggere nel doppio cognome) anche la Corte di Giustizia UE (C-148/02) è intervenuta ad affermare che il comportamento dello Stato di residenza che rifiutava la correzione costituisce discriminazione in base alla nazionalità vietata dagli artt. 12 e 17 del Trattato.
Gli articoli 3 e 23, 4 comma del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'assemblea generale dell'ONU il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, prevedono, rispettivamente, l’impegno degli Stati a garantire l’eguale diritti degli uomini e delle donne a godere dei diritti civili e politici previsti dal Patto e ad adottare le misure per garantire ai coniugi l'eguaglianza nel rapporto matrimoniale e al momento dello scioglimento di tale rapporto.
Decisioni recenti degli organi di vertice della nostra giurisprudenza convergono nel sostenere l’equiparazione del nomen materno a quello paterno nell’onomastica della prole.
Il parere del Consiglio di Stato n. 515 del 2004 contiene un ampio riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome, a fronte della quale “la sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome [, come ad es. la] lesione del pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi di una persona e del suo status giuridico e sociale [o, ancora, possibili] confusioni nella imputazione di significativi rapporti sociali”. Per contro, nella stessa pronuncia i giudici di Palazzo Spada ritengono meritevoli di apprezzamento motivazioni quali la fruizione del “nuovo cognome” per ragioni affettive, o per il significato che quel cognome eventualmente rivesta nella comunità sociale in cui il richiedente è inserito. Va notato che si tratta di un parere reso a fronte di una richiesta di sostituzione del cognome materno a quello paterno; ma queste argomentazioni hanno rilievo a fortiori nell’ipotesi di mera aggiunta.
Nello stessa direzione si muove la Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 12641 del 2006 invita a imitare le esperienze giuridiche di Paesi a noi vicini, dalle quali si evince l’esistenza di una tendenza che abbandona il principio dell’automatica attribuzione del cognome, optando per una soluzione che, rispettosa dell’uguaglianza dei coniugi, lasci questi ultimi liberi di scegliere - sia pure entro certi limiti - il cognome da trasmettere alla prole.
Fondamentale risulta infine l’orientamento del giudice delle leggi. Nell’ordinanza n. 61 del 2006 la Corte Costituzionale sostiene che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia [...] e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.Con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 la Corte costituzionale ha affermato che il nuovo testo dell'art. 117 Costituzione, colmando la lacuna esistente nella disciplina previgente, in conseguenza della quale la violazione di obblighi internazionali derivanti da norme di natura convenzionale non contemplate dall'art. 10 Cost. e dall'art. 11 Cost. da parte di leggi interne comportava l'incostituzionalità delle medesime solo con riferimento alla violazione diretta di norme costituzionali (348/2007), ha previsto l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme con la conseguenza che la norma nazionale con le stesse incompatibile viola per ciò stesso l’art. 117 Costituzione perchè la norma convenzionale, alla quale la norma costituzionale fa rinvio mobile, dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata norma interposta (348/07).
Con la ratifica del trattato di Lisbona, si dovrebbe poi aprire la strada all’applicazione diretta delle norme del trattato stesso e di quelle alle quali il trattato fa rinvio e al controllo di costituzionalità che, anche nei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario non può essere escluso:
a) quando la legge interna è diretta ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza dei trattati della comunità in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi;
b) quando venga in rilievo il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona;
c) quando si ravvisa un contrasto fra norma interna e direttiva comunitaria non. dotata di efficacia diretta (Corte Cost., 13 luglio 2007, n. 284).
Con l'ordinanza n. 176 del 1988 la Corte Costituzionale aveva affermato che sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anzichè avvalersi dell'autorizzazione a limitare l’uno in funzione dell'altro. Con la sentenza n. 61 del 2006, inoltre, la Corte ha ribadito, ancora più nettamente, che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna. In entrambi i casi la Corte ha implicitamente sollecitato un intervento del legislatore che, pur avendo affrontato il tema da ormai quasi un trentennio non è ancora pervenuto a soluzioni concrete.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione del 25 gennaio 1999, n. 63, ha ritenuto illegittimo il rifiuto dell’autorità amministrativa di consentire l’aggiunta del cognome materno a quello paterno, in caso di consenso di entrambi i genitori e di uso di tale cognome nel contesto familiare, scolastico e sociale, anche tenendo conto dell'evoluzione della coscienza sociale e del contesto europeo, e, con parere del 17 marzo 2004, n. 515, reso nell’ambito di un procedimento iniziato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha ritenuto fondata la richiesta al Ministro dell'interno, concordemente formulata dai genitori, per il cambiamento del cognome del figlio legittimo con l'attribuzione del cognome materno, motivata con ragioni di riconoscenza nei confronti del nonno materno, ritenendo non irrinunciabile il diritto al cognome paterno e non condivisibile la motivazione secondo la quale la sostituzione del cognome comprometterebbe lo status di figlio legittimo e i valori della famiglia fondata sul matrimonio..
